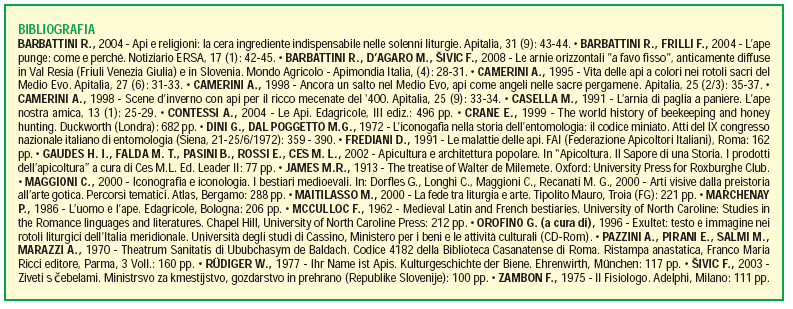|
L’Elogio delle api Laus Apium in latino: “Apis ceteris, quae subiecta sunt homini animantibus antecellit. Cum sit minima corporis parvitate, ingentes animos angusto versat in pectore, viribus imbecilla sed fortis ingenio. Haec explorata temporum vice, cum canitiem pruinosa hiberna posuerint, et glaciale senium verni temporis moderata deterserint, statim prodeundi ad laborem cura succedit; dispersaque per agros, libratis paululum pinnibus, cruribus suspensis insidunt, prati ore legere flosculos; oneratis victualibus suis, ad castra remeant, ibique aliae inaestimabili arte cellulas tenaci glutino instruunt, aliae liquantia mella stipant, aliae vertunt flores in ceram, aliae ore natos fingunt, aliae collectis et foliis nectar includunt. O vere beata et mirabilis apis, cuius nec sexum masculi violant, foetus non quessant, nec filii destruunt castitatem; sicut sancta concepit virgo Maria, virgo peperit et virgo permansit.” Anche se talune affermazioni sono state sconfessate dalla ricerca scientifica, si riporta la traduzione letterale del brano: “L’ape è superiore a tutti gli altri esseri viventi che sono soggetti all’uomo. Pur molto piccola di corpo, rivolge tuttavia nell’angusto petto alti propositi; debole di forze ma forte d’ingegno. Essa, dopo aver esplorato l’alternare delle stagioni, allorché il gelido inverno smise l’imbiancamento e poi il clima moderato della primavera spazzò via il torpore glaciale, subito sente la preoccupazione di uscire al lavoro; e le api sparse per i campi, librando leggermente le ali, si posano appena con le agili zampe per cogliere con la bocca i piccoli fiori del prato, cariche del loro cibo rientrano negli alveari e qui alcune con arte inestimabile costruiscono cellette con tenace cera, altre immagazzinano il fluido miele, altre tramutano in cera i fiori, altre danno forma ai loro piccoli lambendoli con la bocca, altre incamerano il nettare delle foglie raccolte. ?O ape veramente beata e mirabile, di cui i maschi non violano il sesso, né lo turbano i feti, né i figli distruggono la castità; così come, nella sua santità, Maria concepì vergine, partorì vergine e vergine rimase.“ |


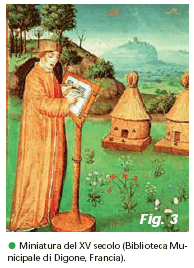 L’illustrazione della fig. 1 proviene da un manoscritto francese del 1400 relativo al Tractatus de herbis di Dioscoride4 , oggi conservato presso la Biblioteca Estense di Modena. (MARCHENAY, 1986; CRANE, 1999). Essa mostra una donna che sta prelevando miele da due alveari; mentre compie quest’operazione si protegge – con scarso successo, diciamo noi! – il volto con una mano. Ai suoi piedi sta un piccolo orso, noto nemico delle api perché goloso del loro miele (FREDIANI, 1991; CONTESSI, 2004).
L’illustrazione della fig. 1 proviene da un manoscritto francese del 1400 relativo al Tractatus de herbis di Dioscoride4 , oggi conservato presso la Biblioteca Estense di Modena. (MARCHENAY, 1986; CRANE, 1999). Essa mostra una donna che sta prelevando miele da due alveari; mentre compie quest’operazione si protegge – con scarso successo, diciamo noi! – il volto con una mano. Ai suoi piedi sta un piccolo orso, noto nemico delle api perché goloso del loro miele (FREDIANI, 1991; CONTESSI, 2004).
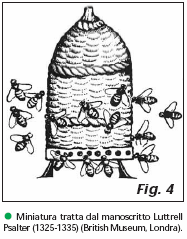
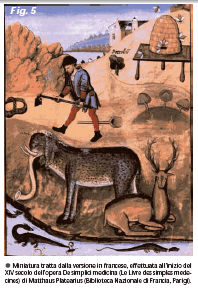
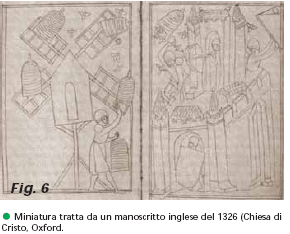 La miniatura rappresentata dalla fig. 4 è tratta dal famoso manoscritto Luttrell Psalter (oggi conservato al British Museum di Londra) scritto e illustrato da scrivani e da artisti anonimi nel decennio 1325-1335. Essa mostra l’antica arnia in paglia (veniva costruita anche con il vimini) molto diffusa nei secoli scorsi, ma ancora presente in alcune realtà apistiche (CASELLA, 1991; GAUDES et al., 2002).
La miniatura rappresentata dalla fig. 4 è tratta dal famoso manoscritto Luttrell Psalter (oggi conservato al British Museum di Londra) scritto e illustrato da scrivani e da artisti anonimi nel decennio 1325-1335. Essa mostra l’antica arnia in paglia (veniva costruita anche con il vimini) molto diffusa nei secoli scorsi, ma ancora presente in alcune realtà apistiche (CASELLA, 1991; GAUDES et al., 2002).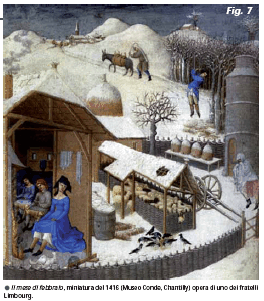 Il manoscritto, capolavoro della cultura francese del Medioevo, Les Très Riches Heures du Duc de Berry8 del XV secolo, conteneva numerose miniature, una per ogni mese dell’anno. Ogni illustrazione è composta da un timpano, a forma di semicerchio, che contiene i due segni zodicali del mese, e da una scena “agreste” che spesso ha sul fondo uno dei castelli di proprietà del Duca (CAMERINI, 1998). Quella rappresentata (fig. 7), del 1416, fa riferimento al mese di febbraio e riporta una scena invernale; oltre all’ovile e alla piccionaia, si notano quattro alveari di paglia, sorretti da un ripiano, coperti dalla neve.
Il manoscritto, capolavoro della cultura francese del Medioevo, Les Très Riches Heures du Duc de Berry8 del XV secolo, conteneva numerose miniature, una per ogni mese dell’anno. Ogni illustrazione è composta da un timpano, a forma di semicerchio, che contiene i due segni zodicali del mese, e da una scena “agreste” che spesso ha sul fondo uno dei castelli di proprietà del Duca (CAMERINI, 1998). Quella rappresentata (fig. 7), del 1416, fa riferimento al mese di febbraio e riporta una scena invernale; oltre all’ovile e alla piccionaia, si notano quattro alveari di paglia, sorretti da un ripiano, coperti dalla neve.