Il controllo biologico
della tarma della cera
La tarma della cera? Una farfalla notturna le cui larve
si alimentano dei favi e di ciò che contengono.
Un tempo era considerata un vero e proprio flagello dell’alveare,
in realtà, determina seri danni quando gli alveari sono
troppo deboli o malati. Ma attenzione, ciò non toglie
che la sua presenza sia pericolosissima nei favi immagazzinati
e perciò va combattuta. La sperimentazione in questione
ci fa conoscere meglio il fenomeno
INTRODUZIONE
La tarma della cera, Galleria mellonella
(foto 1 e 2),

 è una delle tante avversità
con cui devono confrontarsi gli apicoltori,
soprattutto in quelle aree dove
le temperature invernali non determinano
il rallentamento del suo ciclo
biologico. Questo parassita è ubiquitario
e convive negli alveari senza determinare
danni significativi se non
quando la famiglia è composta da un
numero esiguo di api.
è una delle tante avversità
con cui devono confrontarsi gli apicoltori,
soprattutto in quelle aree dove
le temperature invernali non determinano
il rallentamento del suo ciclo
biologico. Questo parassita è ubiquitario
e convive negli alveari senza determinare
danni significativi se non
quando la famiglia è composta da un
numero esiguo di api.
In carenza di soggetti che si occupano
della pulizia dei favi, le uova deposte
dalla Tarma schiudono e danno origine
a giovani larve che trovano nella cera,
nel polline e nei residui della covata,
il nutrimento necessario per il loro
sviluppo.
Solo le temperature al di sotto dei 10-
13 °C rallentano in modo evidente il
ciclo biologico, il quale torna ad essere
rapido non appena le condizioni ambientali
divengono favorevoli.
La lotta a questo Lepidottero è condotta
con trattamenti a base di anidride
solforosa o di insetticidi, determinando
danni ai materiali, rischi di contaminazione
dei prodotti e di possibile
intossicazione per l’operatore.
Considerando il valore economico che
i telaini con favo assumono per l’apicoltore,
risulta di estrema importanza
una loro adeguata e duratura protezione
nel periodo di immagazzinamento.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno
effettuare una prova di confronto
applicando anidride solforosa, normalmente
utilizzata dagli apicoltori nel
controllo di G. mellonella, e un insetticida
microbiologico, allo scopo di valutare
la validità dei trattamenti attraverso
una stima visiva di efficacia.
MATERIALI E METODI
La sperimentazione è stata condotta
presso il Centro Sperimentale per l’Innovazione
Zootecnica (Ce.S.I.ZOO)
dell’Università degli Studi di Milano,
a Cornaredo (MI), in un locale seminterrato,
caratterizzato da un alto tenore
di umidità (75%-85% UR) e di temperatura (23° C), pressoché costante.
Condizioni ottimali per favorire la
schiusura delle uova e lo sviluppo larvale
della tarma della cera (foto 3).
Sono stati utilizzati 30 melari da 8 favi,
suddivisi in 3 tesi da 10 melari ciascuna.
Il materiale è stato stoccato in un laboratorio
di smielatura per un periodo
di 40 giorni dall’estrazione del miele
di acacia, allo scopo di permettere la
schiusura delle uova di Galleria naturalmente
presenti sui favi.
Successivamente si è proceduto alla
classificazione e numerazione di ogni
singolo telaio (foto 4).
I trattamenti hanno avuto inizio il giorno
11 luglio 2005 e le 3 tesi hanno visto
l’utilizzo di:
-
anidride solforosa spray distribuita
dall’alto della pila dei melari (tesi A);
- del prodotto a base di B. thuringiensis
varietà aizawai serotipo (prodotto
commerciale B 401 - Vita-Swarm sas),
diluito in acqua e nebulizzato
secondo quanto indicato dalla casa
produttrice, su ogni lato dei telaini
(tesi B) (foto 5 );
- controllo (tesi C) trattato come il
precedente ma con sola acqua
nebulizzata.




Terminati i trattamenti, i melari sono
stati ricoverati nell’ambiente già descritto,
in presenza di 3 arnie con favi
da nido contenenti Galleria allo stadio
di larve mature, crisalidi e adulti (foto
6 ), allo scopo di reinfestare il materiale
e valutare l’effetto dei trattamenti nel
tempo.
I controlli sono stati eseguiti all’inizio
della sperimentazione e dopo 1, 2 e 7
settimane, effettuando una stima esclusivamente
visiva dei telai distinguendoli
in quattro classi:
-
Danno assente (telaini integri).
- Presenza rosure (debole attività
trofica che non arriva a danneggiare
i favi).
- Presenza di gallerie larvali (favi
danneggiati ma ancora recuperabili).
- Compromissione del favo (danno
grave che rende i favi non riutilizzabili).
RISULTATI
Per quanto riguarda la Tesi A, osservando
nel dettaglio l’andamento dell’infestazione,
si è notato come, dopo
un primo rallentamento dell’attività
dovuto all’effetto abbattente dell’anidride
solforosa, ci sia stata successivamente
una ripresa del danno che ha
portato, nell’ultimo controllo, alla compromissione
del 3% dei favi. Quelli integri
sono passati dal 73% all’inizio della
prova, al 21% (grafici 1-2) alla fine
della sperimentazione.
Nella Tesi B, dove si è utilizzato il prodotto
a base di B. thuringiensis, si può
notare come (grafici 3-4), anche nella
fase finale, cioè dopo 7 settimane dal
trattamento, la compromissione totale
dei favi sia rimasta a livello zero,
mentre ben il 56% non presentava alcun
tipo di attività trofica.
Il controllo (Tesi C) ha visto il 18%
dei favi completamente compromessi,
mentre solo l’1% è rimasto integro
(grafici 5-6 ). Per avere una più chiara
visione dell’efficacia dei trattamenti,
nella tabella seguente si è voluto mettere
in evidenza la possibilità o meno
di riutilizzo dei telaini.
Nella prima riga si sono accorpate le
prime tre classi: quella riguardante i telaini
integri e le due con danno di entità
diversa, ma che non arriva a pregiudicare
il riutilizzo degli stessi; nella
seconda è riportata la percentuale di
telaini definitivamente compromessi.
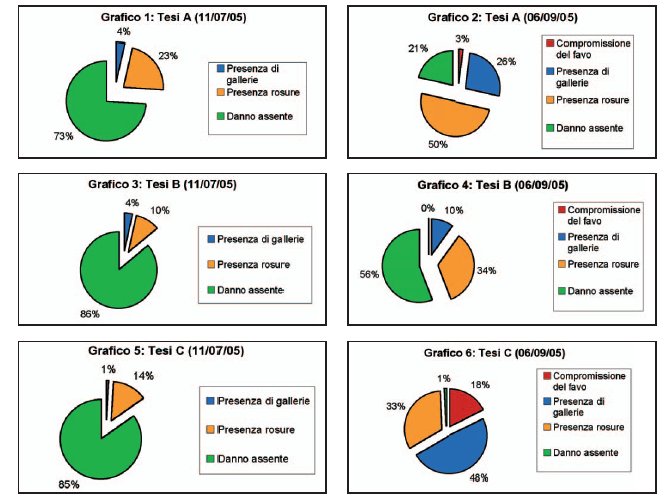
CONCLUSIONI
Osservando l’evoluzione dei danni nel
tempo, si possono desumere utili indicazioni:
nella Tesi A (trattamento con
anidride solforosa) e, ancor di più nel
controllo (Tesi C), l’infestazione, e
quindi i danni conseguenti, hanno continuato
a progredire e sicuramente, se
la prova si fosse protratta oltre le 7 settimane,
i telaini completamente compromessi
avrebbero raggiunto livelli
molto più elevati.
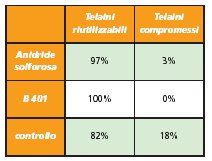 Nel caso della Tesi B (trattamento con
B. thuringiensis) si è assistito alla morte
delle larve neonate che, dopo aver
iniziato a provocare una lieve rosura,
hanno cessato di alimentarsi determinando
un danno ininfluente sulla possibilità
di riutilizzo dei telaini.
Nel caso della Tesi B (trattamento con
B. thuringiensis) si è assistito alla morte
delle larve neonate che, dopo aver
iniziato a provocare una lieve rosura,
hanno cessato di alimentarsi determinando
un danno ininfluente sulla possibilità
di riutilizzo dei telaini.
(<---vedi tabella
)
Ricordando che la sperimentazione è
stata condotta cercando di creare il più
possibile le condizioni ottimali di sviluppo
della Galleria naturalmente presente
sui favi, e fornendo la possibilità
di successiva reinfestazione, si può
senz’altro ipotizzare come un uso tempestivo
del prodotto, ad esempio dopo
la pulizia dei melari da parte delle
api e prima del loro stoccaggio in magazzino,
possa offrire una protezione
totale nei riguardi dell’attacco di G.
mellonella nel tempo.
In conclusione si può affermare,
nonostante l’empiricità e i conseguenti
limiti scientifici di questa prova, come
questo prodotto a base di B. thuringiensis
abbia una effettiva attività di
contrasto sullo sviluppo di G. mellonella
e come possa fornire un supporto
efficace all’apicoltore nella protezione
dei favi immagazzinati.
Mauro Veca
Tecnico apistico
Istituto di Entomologia agraria,
Università degli Studi di Milano

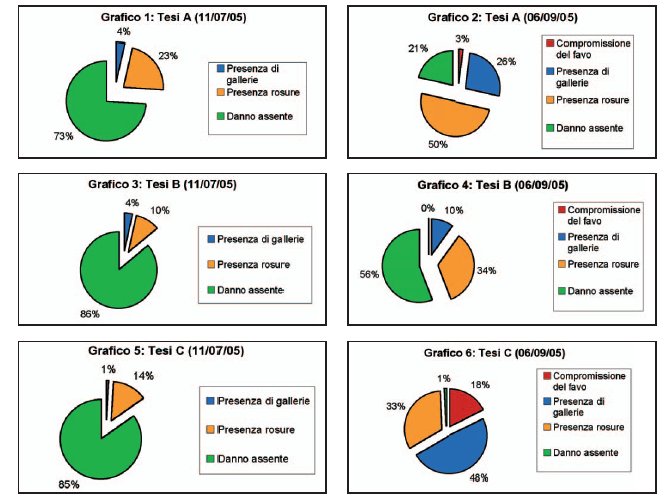

 è una delle tante avversità
con cui devono confrontarsi gli apicoltori,
soprattutto in quelle aree dove
le temperature invernali non determinano
il rallentamento del suo ciclo
biologico. Questo parassita è ubiquitario
e convive negli alveari senza determinare
danni significativi se non
quando la famiglia è composta da un
numero esiguo di api.
è una delle tante avversità
con cui devono confrontarsi gli apicoltori,
soprattutto in quelle aree dove
le temperature invernali non determinano
il rallentamento del suo ciclo
biologico. Questo parassita è ubiquitario
e convive negli alveari senza determinare
danni significativi se non
quando la famiglia è composta da un
numero esiguo di api.



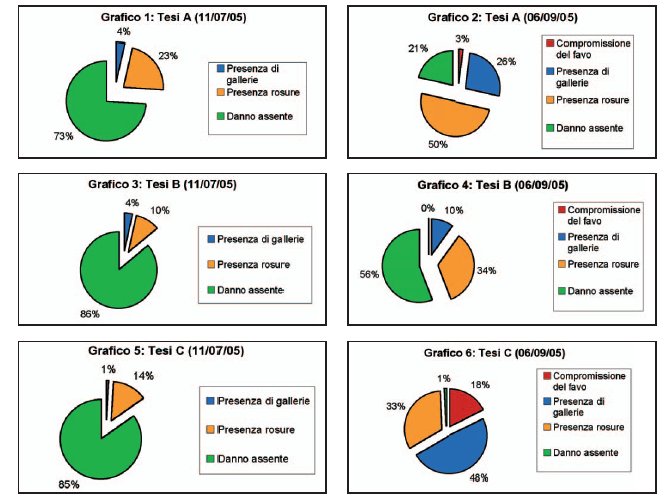
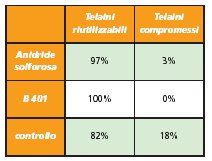 Nel caso della Tesi B (trattamento con
B. thuringiensis) si è assistito alla morte
delle larve neonate che, dopo aver
iniziato a provocare una lieve rosura,
hanno cessato di alimentarsi determinando
un danno ininfluente sulla possibilità
di riutilizzo dei telaini.
Nel caso della Tesi B (trattamento con
B. thuringiensis) si è assistito alla morte
delle larve neonate che, dopo aver
iniziato a provocare una lieve rosura,
hanno cessato di alimentarsi determinando
un danno ininfluente sulla possibilità
di riutilizzo dei telaini.